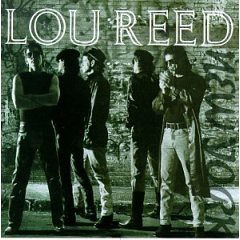La casa era buia, il letto ancora sfatto, nel lavello posate e piatti di due giorni stagnavano maleodoranti. Taddeo diede uno sguardo alla copertina verde con le scritte salmone, rimise la puntina sull’inizio del disco e si ributtò sul divano.
Dall’altoparlante cominciò a gracchiare una voce che pareva femminile – “take me back to the dear old Blighty” – e, improvvisa, la chitarra di Johnny Marr trascinò la sezione ritmica con un duro riff.
E Morrissey inveiva, inveiva – “Has the world changed, or have I changed?”. Taddeo prese in mano la copertina, nella penombra riusciva a distinguere quello che aveva imparato fosse un irriconoscibile Alain Delon, una foto del 1965, sdraiato, forse morto in qualche film. Taddeo era sempre stato convinto fosse una specie di film dell’orrore tratto dai racconti di Poe in cui Delon interpretava uno perseguitato dal suo doppio. Ma non aveva mai verificato.
“Life is very long, when you’re lonely”. Chissà se Milly era molto sola, e quindi aveva voluto abbreviare la sua vita con quel salto. Non era così che se la ricordava. Se la ricordava vitale, somigliava di più alla marcetta di Frankly, Mr Shankly che alla melanconia di I know it’s over. Ma la realtà si scontrava con i suoi mesti ricordi. Lei aveva abbandonato volontariamente questo cazzo di mondo. E lui non aveva nessun diritto di pensare che una come lei non potesse arrivare a suicidarsi, d’altronde non le aveva quasi più parlato da quello schifoso pomeriggio. E anche lui non poteva dire Never had no one ever. Poteva solo pensare di incontrarla oltre quei Cemetry gates, qualche volta, forse. Certo non col brio che emanava quella canzone.
“Sweetness I was only joking when I said I’d like to smash every tooth in your head” cantò Taddeo. E il pensiero andò a tutte le cose offensive dette a lei dopo la rottura, non tante per la verità, e a quelle pensate, queste molte di più. Non c’era rimedio, non poteva riparare, non che pensasse che a lei importasse qualcosa, ma solo per stare meglio con se stesso.
Gli venne in mente una cosa che aveva sentito una sera di capodanno in una chiesa gelida: era la tappa finale di una marcia della pace interreligiosa, Taddeo ci era stato trascinato da Susy, impietosita dal fatto che lui non si era organizzato nulla per le feste. E così Taddeo si era intrufolato nel gruppo di attivisti cattolici e vicari in tutù, amici di Susy, aveva marciato per ore nei vicoli sotto una tormenta di neve, nel capodanno più gelido che Genova avesse mai visto.
A mezzanotte, il gruppo di volenterosi era giunto in una cattedrale di S.Lorenzo ghiacciata, con il solo conforto di una tazza tiepida di té e di una fetta di pandolce casereccio, aveva ascoltato una lunga messa solenne e, quando Taddeo pensava di svenire per la noia e il freddo, erano iniziati gli interventi dei vari rappresentanti delle comunità religiose, ebrei, mussulmani, cattolici, protestanti, buddisti, sul tema del perdono. I discorsi erano interessanti, quasi appassionanti, e a Taddeo era rimasto impresso quello che il membro della comunità valdese aveva detto: la prima cosa era che era più facile concedere il perdono che chiederlo, perché chi perdona ritiene di essere nel giusto mentre chi viene perdonato ammette di aver sbagliato. Ma la cosa che più gli era rimasta impressa era la regola ferrea: il perdono lo concede solo chi ha subito il torto, non il prete, non la chiesa, non i parenti, ma chi ha subito l’offesa. Per questo l’omicidio è così sconvolgente anche per l’omicida, egli sa che non potrà mai ottenere perdono da chi ha ucciso. E i parenti della vittima possono perdonare solo per il dolore arrecato a loro, ma non per il defunto.
Questo significa la morte, non aver più la possibilità di perdonare.
“A murderous desire of love” Morrissey cantava e Taddeo ritornò ai giorni in cui si sentiva in quel modo. La voglia di non vedere nessuno, perché nessuno poteva capire e non forse non voleva nemmeno.
La mattina presto andava in giro, da solo, con la macchina fotografica pronta a cogliere quei barlumi di verità che poteva catturare: un viso stanco e scavato, uno scorcio di mare del giusto colore, un autobus che apre le porte alla fermata, due persone che si incrociano con gli sguardi, uno spicchio di cielo con la giusta proporzione di nuvole. Poi, quando finiva il rullino, si precipitava a farlo sviluppare in quei posti che lo fanno in un paio di ore, tanto non era la qualità che importava per Taddeo, era la verità. Poi, verso l’ora di pranzo, scendeva giù in cantina, chiudeva la porta, ricopriva le fessure con panni neri, spegneva le luci e cominciava a giocherellare con liquidi, stampe, dissolvenze e colori. Con il mangianastri che sparava gli Smiths, i Cure e quanto di più distruttivo c’era per l’animo di un adolescente, prendeva i negativi, li sovrapponeva, li mischiava, li sovraesponeva fino a creare quella perfezione che fuori da quella buia stanza umida faticava a manifestarsi, quell’intersecarsi di cause ed effetti certi che il mondo fuori da lì rifiutava. E nella luce rossa, l’unica concessa per quel tipo di verità, si struggeva e rimpiangeva che un double decker bus non avesse spazzato via lui insieme a lei, in quel momento di gioia perfetta che pochi mesi prima aveva assaporato. Ma quanto si era sbagliato, dopo tutto alcune ragazze sono più grosse di altre, qualunque cosa questo significhi. E così arrivava a notte fonda, tornava in casa, raccoglieva qualcosa da mettere sotto i denti, e, con il pacchetto di fotografie appena stampate, si rifugiava in camera sua, dove sarebbe uscito solo la mattina seguente.
E accompagnando i pensieri circolari persi in quel recente passato, la puntina arrivò a sfiorare il verde centro del disco che ruotava. Era ora di alzarsi.
E rimettere la vita a posto.